|
Famosi acquedotti romani e le sue acque
I Romani con le loro monumentali costruzioni hanno reso gli acquedotti
imponenti, ma non possiamo dar loro il merito di avere introdotto (anche se vi
hanno apportato migliorie) la tecnica della condotta delle acque. Questo sistema
era gia conosciuto ed usato dal più antico popolo mesopotamico dei Sumeri. I
loro condotti erano costruiti con mattoni ed a volta per avere un miglior
drenaggio e un maggiore scolo delle acque. Lo stesso Strabone ci porta a
conoscenza di un sistema chiamato "cochlis" per fare salire l'acqua ai
giardini pensili di Babilonia. Nella città Assira di Bavian, un'iscrizione ci
porta a conoscenza di un acquedotto a vasche degradanti che serviva a portare
acqua potabile alla città di Nivive.
Molti degli acquedotti che troviamo scavati nella roccia in Giudea, in Samaria e
in Galilea, sono di origine fenicia, ma gli stessi Fenici costruttori del
celebre acquedotto di Tiro, appresero questa tecnica dagli Ittiti. Resti di
condotti sono stati ritrovati nel palazzo di Cnosso, sotto un pavimento, altri
ad Argo, a Micene, a Tirinto e Itaca. Omero stesso ricorda l'esistenza di questi
condotti presso la casa di Ulisse. Gli acquedotti greci sono molto diversi e
hanno anche diversa provenienza. Quelli che approvvigionavano la città
di Atene e la circostante pianura fino al Pireo erano una complessa rete di
condotti sotterranei costruiti in pietra e ricoperti di lastre oppure di
tegole con pozzetti di aerazione. Poche e frammentarie sono le notizie che
abbiamo in merito agli acquedotti etruschi, ma conoscendo le loro abilità
e capacità
idrauliche, si può
senz'altro dire (senza essere smentiti) che la tecnica dei condotti scavati
nel sottosuolo o nella roccia fosse già
di loro conoscenza. Se invece dobbiamo parlare dell'acquedotto come
monumentale opera sopraelevata non vi è
alcun dubbio: è
quello romano, come stanno a dimostrare le testimonianze scritte dal "curator
aquarum" Frontino, Vitruvio e Plinio.
Oltre al libro scritto da Frontino, Vitruvio e Plinio (libro vitruviano),
l'opera più importante sull'argomento è il “De aquæ ductu urbis Romæ”
scritto da Sesto Giulio Frontino nel I sec. d.C., periodo in cui aveva
l'incarico di "curator aquarum". Detto libro è composto da una
prefazione e da diversi capitoli in cui tratta argomenti specifici come derivare
l'acqua con tubi di piombo (“fistulæ”). Si parla inoltre degli addetti a
ripartire in modo equo l'acqua nelle case e nelle vie e della regolare pulizia
degli acquedotti ad opera dei fontanieri (“aquarii”) e delle astuzie (f”raudes”),
così chiamate quelle "azioni" a cui spesso i fontanieri ricorrevano
per fornire agli osti (“tabernarii”) una maggiore quantità d'acqua, a danno
del pubblico. Come possiamo vedere molti anni, addirittura secoli, sono passati
ma nulla è cambiato sotto il sole.
Quando erano in funzione i primi acquedotti, soltanto l'acqua in eccesso
"acqua caduca" veniva concessa ai bagni pubblici e solo dopo aver
pagato un canone. Invece l'uso dell'acqua per i privati, era gratuito oppure
dato in cambio di servizi resi allo stato o come "beneficia principis".
Vitruvio invece ci porta a conoscenza di una amministrazione idrica ben diversa,
elaborata da lui stesso o da Agrippa, nella quale, da parte dei privati vi era
l'obbligo, sulla base di un contratto con lo Stato, di pagare una tassa. Con
tale sistema si volevano eliminare tutti privilegi avuti con le concessioni
individuali e gratuite e tutti gli allacciamenti abusivi. Leggendo le cronache
di vita quotidiana dell'epoca si viene a conoscenza che, a Roma, nonostante le
grosse canalizzazioni di piombo che portavano l'acqua dagli acquedotti alle
abitazioni private, la si poteva utilizzare soltanto al pianterreno delle insulæ,
dove abitavano i più
facoltosi. Gli abitanti dei piani alti erano costretti a procurarsi l'acqua
alla più
vicina fontana e questo rendeva difficile la cura della pulizia. Giovenale
nelle sue Satire cita spesso i portatori d'acqua (“aquarii”),
segno che erano necessari alla vita collettiva d'ogni stabile. In effetti
nessuna costruzione ci ha ancora rivelato le colonne montanti che avrebbero
permesso di portare l'acqua ai piani più
alti.
Per la costruzione degli acquedotti e per la loro, non meno importante
manutenzione, il compito era affidato ai censori e in mancanza di loro agli
edili aiutati da altri funzionari: adiutores, architecti, curatores,
procuratores. Sotto l'aspetto finanziario erano preposti i censori, coadiuvati
dai questori, mentre i magistrati amministravano il tesoro dello stato.
Nel 146 a.C. il pretore Marcio ebbe l'incarico dal Senato di fare riparare gli
acquedotti logorati dal tempo (“quassati
venustate”)
e di infliggere pesanti pene verso quei privati che si erano allacciati alle
condutture pubbliche in maniera abusiva (“fraudes
privatorum”).
Agrippa, avuto il compito dall'Imperatore Augusto di occuparsi delle acque, lo
portò
a termine servendosi di 240 schiavi di sua proprietà.
Alla morte di Agrippa, fu l'imperatore stesso ad assumere l'incarico della “cura
aquarum”,
attraverso un funzionario del senato, il “curator
aquarum”,
che da un suo apposito ufficio svolgeva l'incarico affidatogli. Colui che
ricopriva detto incarico era posto ai livelli più
alti della carriera pubblica, aveva privilegi e onori propri dei magistrati
ed aveva a disposizione un vasto seguito di assistenti.
La specifica funzione dell'ufficio delle acque era quella di mantenere in piena
efficienza gli impianti ed intervenire ove necessario per il suo completo
ripristino, riportando così
l'impianto alla sua massima capacità
di approvvigionamento idrico. Numeroso personale faceva parte di questo
ufficio. In esso vi erano: architecti o ingegneri idraulici, misuratori (“libratores”),
quelli che mettevano in opera le tubazioni (“plumbarii”),
gli operai (“aquarii”),
i segretari, gli archivisti e gli amanuensi.
FAMOSI ACQUEDOTTI ROMANI E LE SUE ACQUE
L'ACQUA APPIA: fu portata a Roma da Appio Claudio Cieco, nel 512 a.C.;
attraverso un acquedotto lungo circa sedici chilometri (quasi tutto sotterraneo)
con una portata di acqua giornaliera di 73.000 mc. Detto acquedotto fu costruito
con blocchi di tufo dotati di una cavità posta al centro del blocco.
L'ANIO VETUS: nel 272 a.C. il censore Mario Curio Dentato fece costruire il
secondo acquedotto di Roma. Questo acquedotto si snodava per circa 63 chilometri
ed anch'esso era interrato. Fu così
chiamato perché
l'acqua da cui proveniva aveva origine dalla valle dell'Aniene. La sua
Portata totale era di centosettantacinquemilanovecentoventi metri cubi di
acqua al giorno. E' da ricordare che un ramo secondario di questo acquedotto
portava acqua alle terme di Caracalla.
L'ACQUA MARCIA: l'acquedotto dell'Acqua Marcia fu fatto costruire nel 114 a.C.
da Q. Marcius Rex, pretore urbano da cui prende il nome. Le sorgenti da cui ebbe
origine questo acquedotto si trovavano al Km 61,5 della via consolare Tiburtina
Valeria.
L'ACQUA TEPULA: la costruzione dell'acquedotto fu ultimata nel 125 a.C. ad opera
dei censori C.N. Cepione e L. Cassio Longino. La sorgente di questo acquedotto
era presso i Colli Albani e le fu dato il nome di "Tepula" perché
la sua temperatura non scendeva mai al di sotto dei 16-17 gradi (temperatura
piuttosto calda per l'acqua). Essa seguiva lo stesso percorso dell'Acqua
Marcia e la portata giornaliera era di 17.800 mc. A partire dal 33 a.C.
attraverso un canale sotterraneo l'Acqua Tepula fu miscelata con l' Acqua
Julia, rendendola così
più
gradevole.
L'ACQUA JULIA: l'acquedotto dell'Acqua Julia fu costruito da M. Vispasio Agrippa
nel 33 a.C., con lo stesso percorso di quelli dell'Acqua Tepula e dell'Acqua
Marcia. L'acqua che vi scorreva, oltre ad essere di ottima qualità
era anche leggermente frizzante.
L'ACQUA VERGINE: fu portata a Roma da Agrippa nel 19 a.C. Le sue sorgenti sono
vicine a quella dell'Acqua Julia. Questo acquedotto aveva un condotto tutto
sotterraneo ed
è
ancora oggi in uso (nonostante i suoi duemila anni di storia). Quest'acqua
alimentava anche le terme di Agrippa.
L'ACQUA ALSIETINA:
detta anche Acqua Augusta, fu portata a Roma da Augusto nel 2 a.C. Partendo
dai laghi Martignano e attraversando il Gianicolo, dopo aver percorso 32.815
metri, giungeva a Roma. Questo acquedotto aveva una portata di 15.600 mc.
Poiché l'acqua era di origine lacustre è da immaginare che essa venisse
usata solo per irrigare i campi o per allagare il circo dove venivano svolte
le battaglie navali. Detto circo si trovava nelle vicinanze delle attuali
piazza Santa Maria e piazza San Cosimato in Roma.
L'ACQUA
CLAUDIA: questo acquedotto fu iniziato da Caligola nel 38 d.C. (insieme all'
Anio Novus) ma terminato da Claudio nel 52 d.C. ed è
tra le più
grandiose realizzazione eseguite. L'acqua veniva prelevata nella valle dell'Aniene
e seguendo un percorso di circa 69 km, di cui 15 allo scoperto e circa 16 su
arcate di tufo, e in parte fiancheggiando altri grandi acquedotti come Acqua
Marcia, Anio Vetus e Novus, l'acquedotto giungeva a Roma.
L'ANIO
NOVUS: anche questo acquedotto, come quello dell'Acqua Claudia, fu iniziato
da Caligola nel 38 d.C. e portato a termine da Claudio nel 52 d.C. Questo
acquedotto prelevava l'acqua direttamente dal fiume Aniene (da cui il suo
nome) e rappresenta senza dubbio la più
imponente costruzione idraulica dell'antica Roma, con i suoi ottantasette
chilometri di lunghezza di cui quattordici su archi ed una portata di
duecentomila metri cubi al giorno. Questa costruzione permetteva di
distribuire l'acqua anche alle zone più
alte della città.
ACQUA TRAIANA: questo
acquedotto fu costruito da Traiano nel 109 d.C. L'acqua veniva prelevata da
alcune sorgenti nei pressi del lago di Bracciano e dopo aver percorso circa
trentatrè chilometri, costeggiando la via Cassia, la Clodia ed infine l'Aurelia,
giungeva al Gianicolo. Questo acquedotto servì anche ad alimentare le terme
di Traiano.
ACQUA
ALEXANDRINA: l'acquedotto Alessandrino è
l'ultimo in ordine di tempo. Fu fatto erigere dall'Imperatore Alessandro
Severo intorno all'anno 226 d.C. L'acqua giunge a Roma su tipiche arcate
rivestite di laterizio e fu utilizzata anche per alimentare le terme
Alessandrine che altro non sono che il rifacimento delle terme di Nerone nei
pressi di Campo Marzio.
I
nove più antichi acquedotti romani avevano una capacità totale circa
992.200 mq al giorno.
Se
si pensa che la popolazione in età
traianea a Roma era di circa un milione di abitanti, vi era una disponibilità
di circa 1000 litri per abitante. Questo sta a dimostrare l'importanza che
le autorità
Romane dell'epoca davano all'acqua nella vita domestica di ogni giorno.


Acquedotto
Alessandrino
Acquedotto Claudia
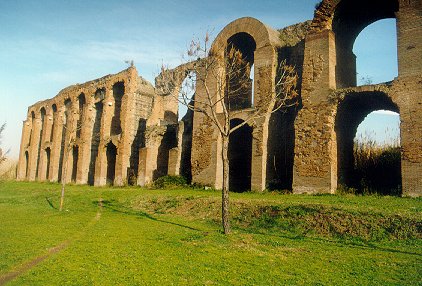

Acqua
marcia
Resti di
acquedotto
|